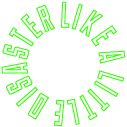“Superhost”
Antonio Trotta, Virginia Francia, Lisetta Carmi, Flavio Favelli, Egill Sæbjörnsson, Polina Miliou, Theo Triantafyllidis, Acero, Roman Luterbacher, Ingo Gerken, Denisas Kolomyckis, Traslochi Emotivi, Tom Putman, Julia Colavita, Julie Monot, Paul Branca, Angelo Iodice, Hilario Isola, Anita Pankoff, Alessia De Pasquale, Davide Mingolla, TPF-The Philosophical Furniture, Kitty Clark, Mikko Kuorinki, Arianna Ladogana, Daniela Corbascio, Marc Giloux, Minhong Pyo, Hayat Çolak, Paige Silverman, Natalia Janula, Steven Gee and David Stearn, Corey Bartle-Sanderson, Perce Jerrom, Simon Foxall, James Sibley, Silvana Di Blasi, Mariantonietta Bagliato, Eva Hide, Donato Trovato, Giancarlo Norese, Irene Pucci, Dionysis Saraji, Michela Rondinone, Lucia Uni, Daniele Parioperra, Antonio Milano, Martina Petrelli & Choxee, SET Napoli + Mariangela Giustini, Irina Hale, DICIASSETTE.
Superhost è un progetto ideato da Like A Little Disaster e curato in collaborazione con Ferragosto Project e Flusso Project.
QUANDO:
La mostra sarà inaugurata Domenica 17 Agosto, dalle ore 19, con la performance Per Diem di Denisas Kolomyckis alle 19:30.
Dal 18 Agosto la mostra sarà visitabile su appuntamento attraverso l’indirizzo email likealittledisaster@gmail.com
DOVE:
Strada pozzo Amendola 24 – Cisternino (Br)
https://maps.app.goo.gl/ZPSjEQYEyPsu8nxz8
In un ecosistema completamente overturistificato come quello della Puglia, SUPERHOST utilizza la strategia del camuffamento come ipotesi ironica/critica di resistenza, adottando una logica post-human e post-identitaria. È una figura transiente, una zona liminale tra hospitality e ostilità, tra reale e fittizio, che incarna la logica della simulazione in senso: non una copia del reale, ma il suo annullamento attraverso l’eccesso di segni.
SUPERHOST è un Airbnb reale/fittizio che si manifesta attraverso un’identità dissolta in un processo camaleontico permanente, un dispositivo relazionale che si plasma secondo i flussi dell’algoritmo e delle recensioni, seguendo un modello rizomatico in senso deleuziano. In questa dissoluzione dell’identità nel reticolo dei desideri e delle aspettative turistiche, si produce una performatività ambientale che somiglia alla figura del cyborg: né natura né cultura, né host né guest, ma interfaccia.
Emergendo come un sistema complesso di strategie di presentazione (di me stesso, del vicino) e di rappresentazione (del sé, degli altri), SUPERHOST opera secondo forze in gioco che ridefiniscono, riorganizzano e ri-spiegano le forme del visibile. È una zona estetica contaminata, un ready-made vivente, una mise en abyme della piattaforma. In questa prospettiva, la rappresentazione diventa una protesi culturale, mentre il sé si dissolve nel suo avatar comunicazionale.
La percezione e l’interpretazione di SUPERHOST non hanno nulla a che vedere con i concetti di verità e finzione; qui lo spettacolo prende il posto della realtà. All’interno di questo spazio, non è necessario che i segni siano veri o falsi, ma efficaci. Ciò che conta è la credibilità del simulacro, la capacità performativa del gesto. Il turismo è ormai una tecnologia del sé, una pratica di self-branding immersa nei regimi del visibile, in cui si attivano micropolitiche dello sguardo, regimi di credenza e sospetto.
La messa in scena ribadisce il mantenimento del dubbio, di un duo-habere, ovvero l’impossibilità di trovare una soluzione univoca nell’osservazione, mantenendo vivi entrambi gli estremi della coppia cognitiva vero/falso. È l’estetica dell’ambiguità funzionale, che si inserisce nel cuore dell’economia dell’attenzione, dove il dubbio è valore di scambio.
Lo sguardo, filtro interattivo tra verità e finzione, si lega alle teorie del sightseeing come costruzione sociale dello sguardo, per cui l’esperienza turistica (o, più in generale, quella del consumatore contemporaneo) sarebbe profondamente alterata dal fatto di essere pre-selezionata e pre-confezionata, secondo pacchetti esperienziali vendibili e condivisibili, ridotti a una serie di immagini per Instagram.
L’overturismo non è soltanto una saturazione dello spazio, ma una presa coloniale sull’immaginario. Non invade solo i luoghi: ridefinisce le forme del visibile, dell’atteso, del vivibile. È una macchina mitopoietica che smembra l’alterità in icone e la restituisce in forma di scorcio condivisibile, mentre l’esperienza si dissolve nel rito ottico della fotogenia. Ogni luogo diventa sfondo: non si viaggia per conoscere, ma per confermare ciò che si è già visto – o meglio, scrollato.
Il paesaggio – che un tempo si abitava – oggi si performativizza nella cornice dell’inquadratura. Non si visita più uno spazio, ma un format. La località cede il passo alla sua astrazione: un parco tematico dell’autenticità, una simulazione docile dell’esotico, confezionata per rassicurare più che per disturbare. Un realismo senza realtà.
È la disneyficazione dell’alterità: il mondo si fa decorazione.
Ma il danno non è solo semiotico. C’è un ecocidio in corso, celato dal filtro seppia del lifestyle: consumo idrico e materiale, erosione del suolo, urbanizzazione intermittente, iperproduzione energetica. A questi si aggiungono processi di espropriazione sociale: i centri urbani mutano funzione, gli abitanti diventano comparse a giornata, oppure vengono espulsi ai margini della narrazione turistica, là dove l’indice non arriva, fuori dalla mappa del desiderabile.
L’autenticità non viene più vissuta: viene prodotta, codificata, messa in scena. Un oggetto simbolico tra gli altri, parte di una coreografia performativa pensata per l’algoritmo e il capitale. Quello che un tempo era vissuto ora si consuma. Lo spazio diventa uno spettacolo a flusso continuo: “visibilità senza esperienza”.
Così l’ingiustizia ambientale si annoda all’ingiustizia sociale. Chi subisce il fenomeno non è mai chi lo desidera né chi ne guadagna. I margini si allargano mentre il centro viene saturato. Le “destinazioni autentiche” diventano riserve simboliche del capitale, palcoscenici geopolitici dove la disuguaglianza si maschera da accessibilità, dove la mobilità è solo apparente e la libertà è un servizio premium.
Nel fondo, il turismo massivo è figlio del biocapitalismo tardo, un’industria dell’immaginazione normativa che si appropria anche del tempo liberato. Anche il viaggio viene assorbito dalla logica produttiva: cronometrato, prenotato, calcolato, iper-curato. Il desiderio diventa un pacchetto.
Non si viaggia per perdersi, ma per aggiornare la propria identità.
L’escapismo è già previsto, pianificato, anticipato. Il turista non è più soggetto: è un interpassivo, delega ad altri – influencer, agenzie, IA – il compito di vivere al suo posto. La sua presenza è pura retorica visiva, un’ombra algoritmica nel feed di qualcun altro.
È una figura semi-assente, in bilico tra l’emulazione e il consumo, tra il presente condiviso e l’assenza esperienziale.
Il turismo – nel suo formato attuale – non libera ma anestetizza.
E SUPERHOST, come contro-dispositivo, ironizza, disarticola, sabota.
Restituisce al segno la sua ambiguità, al luogo il suo rumore di fondo.
Nel suo camuffamento permanente, SUPERHOST non cerca di rappresentare:
si dissolve, si moltiplica, si smarrisce.
È un’epifania della soglia: una semiotica dell’inabitabile.
Un contagio mimetico. Una soglia che ci guarda.
Un algoritmo che mente per sopravvivere.
Il turismo di massa è un problema che non nasce solo dai numeri, ma anche da un immaginario condiviso: è così che i social media e i contenuti virali hanno ridisegnato le mappe del desiderio turistico. Non è solo l’eccesso di corpi nei luoghi a renderlo problematico, ma l’uniformità del desiderio che li muove. Viaggiamo seguendo coordinate invisibili, tracciate da algoritmi e virali meccanismi di visibilità. Le mappe del desiderio non nascono più dall’incontro con l’ignoto, ma dalla ripetizione compulsiva dell’identico: stessi scatti, stessi frame, stessi tramonti.Così, la promessa del viaggio come esperienza unica si capovolge nel suo contrario: un rito collettivo di produzione di contenuti, dove il mondo diventa sfondo per il proprio brand personale. Instagram e TikTok non sono più soltanto vetrine, ma dispositivi performativi che colonizzano l’immaginazione prima ancora dei luoghi. Non viaggiamo per vedere, ma per essere visti.
In questo scenario, il turista contemporaneo non esplora: conferma. Non scopre: archivia. Il paesaggio perde la sua alterità e diventa superficie da catturare, ottimizzare, postare. L’orizzonte si restringe: non si viaggia più per perdersi, ma per dimostrare di esserci stati.
Alla fine, la domanda inquietante rimane: viaggiamo ancora per vivere un’esperienza o solo per simularla?
Quando il turismo diventa un fenomeno di massa, l’elemento normalmente necessario al viaggio è la visione: ciò che deve essere visto, filtrato, classificato con una, due o tre stelle in base al suo valore simbolico. L’esperienza è retroattiva: viene validata solo se riconoscibile. La mappa precede il territorio, e ogni deviazione è già prevista dall’algoritmo.
Il dominio della visione, la traduzione delle cose in immagini e la loro normalizzazione reagiscono sulle cose stesse, riducendole alla condizione di museo, giardino botanico, zoo o parco divertimenti. È l’estetizzazione della realtà, dove tutto è superficie, esposizione, messinscena. Come in una vetrina, le cose da vedere subiscono una trasformazione capitalistica: vengono decontestualizzate, rese autonomi oggetti di consumo culturale, vendibili come esperienze certificate.
SUPERHOST esplora l’inautenticità come orizzonte estetico e politico. Non è il mondo a essere finto, ma la nostra modalità di accesso a esso. Il turista non vede le cose, ma la loro messa in scena; non la realtà, ma il suo rendering emozionale. L’immagine è il nuovo reale, e l’autenticità si manifesta solo come simulazione di sé.
L’articolazione spaziale, modellata dall’ansia del verosimile e dell’iconico, assume i tratti di segni di segni, di metadata emozionali che informano ogni spazio. Ciò che si esperisce non è più il luogo, ma il suo riflesso nel sistema di credenze estetiche condivise.
La seduzione prende il posto della persuasione. Il desiderio è indotto, performato, codificato. Il segno è fatto per mentire. Ma in un mondo in cui la verità non è più utile, la menzogna è una strategia di sopravvivenza.
La seduzione prende il posto della persuasione. Il segno è fatto per mentire!
Like A Little Disaster